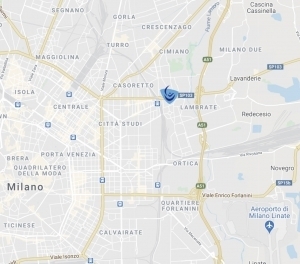Gli incontri della vita: dai legami di sangue alle affinità elettive
conferenza di Stefania Carosi presso l’Associazione pedagogica Il Chicco di grano, Torino, 30-4- 2004
(dal sito www.liberaconoscenza.it )
L’argomento che ci proponiamo di affrontare questa sera ha a che fare con uno degli aspetti fondamentali dell’esistenza: il valore e il senso degli incontri della vita, quegli incontri che scandiscono la nostra esistenza. Esseri umani che intersecano e intessono la loro vita alla nostra, che ci promuovono oppure ci osteggiano, o hanno un atteggiamento di indifferenza… comunque sempre incontri che ci portano delle occasioni nuove per agire, per pensare.
Se ognuno di noi guardasse alla propria biografia, se ripercorresse a ritroso gli anni della propria vita, potrebbe ben dire che alcuni incontri sono stati fondamentali, sono stati dei veri e propri eventi. Un incontro può cambiare la vita, a volte, così come può cambiarla un colpo di fortuna, una malattia, un trasferimento, che so, in Malesia.
La nostra cultura ufficiale, nel suo modo di affrontare le cose guardandole da un punto di vista essenzialmente esteriore, dà agli incontri della vita una valenza, tutto sommato, casuale. A cominciare dal luogo di nascita e dalla famiglia. Per la maggior parte dei nostri contemporanei la nascita di ognuno di noi è il risultato di quel giorno in cui i nostri genitori ebbero un trasporto l’un l’altro così forte che noi fummo concepiti. Dopodiché tutti gli altri incontri della vita sono il frutto di una serie di connessioni causa-effetto, causa-effetto, causa effetto… tutte accidentali, occasionali:
«Sono andato a casa di Tizio e, per caso, ho incontrato Caio che passava di lì»… eccetera, eccetera.
Per una sorta di pregiudiziale di fondo, il senso di tutto questo tessuto di essere umani, che costituisce l’ambito vivente delle nostre relazioni, è oggi considerato del tutto casuale. Molte volte nella mia vita di insegnante, e soprattutto quando insegnavo al liceo, ho avuto con me dei ragazzi che nei momenti di particolare crisi o scontro con i genitori pronunciavano la fatidica frase: «Ma io non ho chiesto di venire al mondo, non ho chiesto di nascere». E queste parole vogliono dire tante cose. Vogliono dire il peso di un’esistenza che si vorrebbe fosse il risultato di una scelta, e invece può accadere che ci venga detto: «Mah, non t’aspettavamo, sei nato per caso…». Oppure vogliono dire che ci sono momenti in cui ci si scontra con un’esistenza che non si sa bene da dove venga e dove vada a parare, e sembra a volte tragicamente beffarda, quasi una trappola nella quale si viene ad incappare. Diversamente, ci sono persone adulte che dicono: «Io non farò nascere figli in un mondo come questo».
Insomma, da una parte c’è chi dice: «Non ho chiesto di venire al mondo» e dall’altra c’è chi afferma: «Non metterò al mondo nessuno». Una sorta di oscillazione tra l’idea di un caso che incombe e l’idea che la nascita di un essere umano dipenda semplicemente dal fatto che una coppia voglia o non voglia avere figli. È chiaro che insieme alla crisi di molti rapporti all’interno della famiglia , ci sono difficoltà
anche fuori dell’ambito famigliare. I cosiddetti «legami di sangue», quelli che ci ritroviamo nascendo, non cambiano mai perché padre, madre, fratelli, nonni, cugini, rimangono tali a vita. Nel corso degli anni, poi, incontriamo altre persone nei confronti delle quali ci muove una «affinità elettiva». Incontrarsi per affinità elettiva non significa però che con questi non-parenti sia di sicuro tutto rose e fiori, come si dice a Roma: vuol dire semplicemente che incontriamo delle persone con le quali sentiamo di avere qualcosa o molto da condividere, qualcosa che ha una reciproca importanza e non dipende dalla parentela. Ma anche in quest’ultimo ambito c’è crisi, come dicevo. Anche riguardo ai rapporti che si presentano «liberi», cioè non imposti dal sangue, si sentono oggi frasi del tipo: «Ma chi sei tu? Che vuoi tu da me? Che c’entri tu nella mia vita?». Queste frasi, per noi, oggi sono normali, ma se penso a mia nonna, posso dire con sicurezza che mai le sarebbe saltato in mente di dire una frase del
genere a chicchessia. Seppure nella sua vita aveva dei rapporti difficili, li accettava, non aveva nemmeno l’idea che si potessero evitare. Me la ricordo, la mia nonna: aveva una vicina di casa, a mio parere tremenda, e io non capivo come mai non l’avesse ancora mandata a quel paese. Eppure lei, tranquillamente, per anni e decenni, ha mantenuto un rapporto reale con quella persona. E più si va indietro nel tempo, nei secoli e millenni, e più c’era non solo un’accettazione spassionata ma addirittura un’istintiva comprensione del significato più profondo di ogni incontro.
Noi oggi — penso di non dire una cosa strana — quando incontriamo una persona per la prima volta siamo un po’ guardinghi, ci scrutiamo, cerchiamo di leggere quali siano le sue intenzioni. Più si va indietro nel tempo, invece, e più gli incontri erano chiari, evidenti nella loro essenza, comprensibili in modo forse elementare ma intenso e sicuro. Se noi, per esempio, leggessimo un brano dell’Odissea, o di un altro testo antico (soprattutto l’epica), se leggessimo un qualunque brano dove due personaggi s’incontrano, vedremmo che non stanno lì a fare le presentazioni: subito l’uno ha chiaro chi è e che cosa vuole l’altro. E così, aprendo una pagina a caso dell’Odissea, mi è capitato l’incontro tra Ulisse a Nausicaa (canto VI, vv.264 e segg.). Ulisse appare a Nausicaa sulle rive dell’isola dei Feaci, mezzo ignudo, stanco, naufrago. E lei:
«O forestier, tu non mi sembri punto
dissennato e dappoco» allor rispose
la verginetta dalle bianche braccia.
«L’olimpio Giove che sovente al tristo
non men che al buon felicità dispensa,
mandò a te la sciagura, e tu da forte
la sosterrai. Ma poiché ai nostri lidi
ti convenne approdar, di veste o d’altro,
che ai supplici si debba ed ai meschini,
non patirai disagio (…)».
Nausicaa sa che Ulisse non è un nemico, sa che deve essere accolto nella bella terra dei Feaci. Poi si rivolge alle ancelle che sono ancora impaurite dallo straniero (del resto l’incontro non le riguarda direttamente) e dice loro:
«(…) In qual parte
fuggite voi perché vi apparse un uomo?
Mirar credeste d’un nemico il volto?
Non fu, non è. E non fia chi a noi s’attenti
guerra portar: tanto agli Dei siam cari.
Oltre che in sen dell’ondeggiante mare
solitari viviam, viviam divisi
da tutto l’altro della stirpe umana.
Un misero è costui, che a queste piagge
capitò errando, e a cui pensare or vuolsi.
Gli stranieri, vedete, ed i mendìchi
vengon da Giove tutti…»
La bellezza di queste parole, di questi dialoghi, è proprio la sicurezza con cui ci si riconosceva: quello è un nemico, quello sarà il padre dei miei figli, quello mi verrà incontro e sarà il momento della mia morte… e così via. Noi abbiamo perso queste sicurezze nell’incontro, ma lo svantaggio di non poter più vivere l’istintualità karmica ha aperto le porte a quella libertà di coscienza che via via abbiamo acquisito.
Chi era presente all’incontro di marzo forse ricorderà quello che allora ho cercato di dire in relazione alla formazione dell’individualità della coscienza e della sovranità del nostro Io, sempre più presente nelle tante vicende dell’esistenza: oggi noi siamo chiamati a dire la nostra anche in relazione agli incontri, non è più possibile limitarsi ad accettarli. È altrettanto chiaro, però, che noi vorremmo poter avere ugualmente delle certezze nelle relazioni, così come le avevano gli antichi. Non per una qualche grazia divina, ma per una nostra autonoma conquista. C’è una scienza, che è la scienza dello spirito — molto poco conosciuta — che è in grado di descrivere oggettivamente, fra le tante cose, anche le leggi dell’incontro fra gli esseri umani.
La realtà costitutiva totale dell’essere umano, quella che permette l’indagine sulle leggi che regolano gli incontri, è quella che vedemmo la volta scorsa: comprendiamo l’uomo per intero solo se consideriamo, oltre alla sua dimensione fisico-vitale, anche quella animica e quella spirituale. Questa integrazione delle conoscenze biologiche e antropologiche correnti è la proposta conoscitiva della scienza della realtà non visibile dell’uomo. Non è un dogma messo lì, è una proposta, un’ipotesi che è bene mettere sull’altro piatto della bilancia. Così come perlopiù diamo per scontato che tutto avvenga per caso (e non è che qualcuno lo abbia dimostrato scientificamente), allo stesso modo possiamo provare a vedere cosa succede se ci mettiamo alla ricerca di un senso oggettivo che guidi questi incontri.
La proposta di fondo che la scienza dello spirito (l’antroposofia) fa è molto provocatoria e suona così: in un mondo che si è sempre occupato dell’immortalità, del «che ne sarà di me dopo la morte?», proviamo a porre una domanda che va messa prima di questa e che dice: dov’ero, io, prima di nascere? Se io anelo o semplicemente ipotizzo che in me ci sia qualcosa di eterno che chiede di permanere anche dopo la morte, non sarà forse che, se è davvero eterno questo mio essere, questo nucleo realissimo nel quale saldamente io mi sento «io», esso ha un’esistenza che precede la mia stessa nascita? Non sarà forse che, così come non muore con la morte terrena, il mio vero essere non nasce con la nascita terrena? Insomma, insieme al quesito dell’immortalità, si pone quello dell’innatalità.
Un quesito recente, in fondo. Un filosofo del calibro di Platone, infatti, dava ancora per scontato che in questa dimensione triplice dell’essere umano (corpo, anima, spirito) la parte spirituale (chiamiamola così) che costituisce il vero essere penetra nel suo luogo di carne, il corpo, solo per un periodo d’esistenza che varia da persona a persona. Oggi una conoscenza ampliata del significato dell’esistenza vede che lo spirito di ognuno ha da svolgere un compito tutto particolare nell’universo, si cimenta affinché la pienezza della sua coscienza possa esprimersi all’interno della materia. Ebbene, in questo lungo cammino evolutivo che mira alla piena compenetrazione dello spirito con la materia — così come il Cristo ha mostrato e compiuto nella sua resurrezione della carne — in questo nostro cammino, che è poco più avanti della metà, noi viviamo essenzialmente nella zona di mezzo, tra il corpo e lo spirito. Viviamo soprattutto nelle forze dell’anima. Questo nostro spirito, infatti, questo nostro Io divino, tentando di compenetrare e guidare gradualmente la sua corporeità (e anche quella del mondo che lo circonda), provoca una sorta di ottundimento della coscienza. La materia, infatti, soprattutto in questo tempo, è particolarmente grave, densa e greve: avvicinandosi ad essa lo spirito eterno provoca come una sorta di risonanza interiore, un’eco multiforme e «rumorosa» che noi chiamiamo anima. È come se lo spirito sbattesse contro le pareti corporee e noi ne sentissimo la presenza, una presenza che diventa altra, che non è solo fisica e non è più solo spirituale, e che chiamiamo anima. È la coscienza di noi stessi, di un pensare, un sentire e un volere che noi sentiamo appartenerci, di un’interiorità di cui siamo al centro. Quest’interiorità di immediato accesso è spesso confusa con lo spirito, ma è l’anima. È ciò che la psicologia di oggi chiama «ego»; Steiner lo chiamerebbe «io inferiore», «coscienza quotidiana». È un io più piccolo, è «la coscienza dell’Io grande», un’immagine riflessa e risonante della nostra vera entità. In questa zona mediana viviamo fortemente e per la maggior parte della nostra giornata.
E allora, in questa immagine triplice dell’essere umano, ecco che un’altra ipotesi di lavoro e d’indagine nella propria vita viene offerta dalla nuova scienza della realtà non visibile: lo spirito individuale ed eterno di ognuno di noi, spirito che è immortale ed anche innatale, ha dietro di sé un lungo cammino durante il quale ha provato più e più volte lo sforzo di diventar sovrano sulla materia, incarnandosi varie volte, confrontandosi con il mondo in epoche diverse, non permettendosi — e questo vale per ogni essere umano — di perdere nessuna delle occasioni evolutive che tutte le civiltà che si sono susseguite nella storia hanno offerto, come dono, a tutta l’umanità per fare dei passi in avanti.
Valendosi di questo straordinario allargamento di orizzonti, la scienza dello spirito — che sarebbe, voglio ripeterlo, la scienza di quelle dimensioni dell’umano che non si vedono e non si toccano, la scienza della realtà sovrasensibile — dice che ogni volta che questo Io s’incarna, la coscienza che noi riusciamo ad averne è quella della cosiddetta personalità. Io in questa vita sono Stefania Carosi, lui è Fabio Delizia, e ognuno di noi nel corso della sua evoluzione ha avuto tante personalità, ovvero tante maschere. In latino, persona vuol dire maschera, la maschera che l’attore metteva a teatro per impersonare ora l’uno ora l’altro personaggio. Quando la rappresentazione finiva questa maschera veniva tolta. La maschera ‘personabat’ (risuonava attraverso)… Che cosa risuonava attraverso? La verità che era data da colui che agiva dietro di essa. L’attore è il nostro Io, mentre la maschera con la quale si presenta è la nostra immagine personale, legata alla specifica incarnazione, a questa vita qui che stiamo ora vivendo. L’anima personale risuona tra corpo e spirito con tante caratteristiche diverse, di volta in volta, di vita in vita. Uno ha un temperamento collerico, o un carattere aperto, e poi in un’altra incarnazione potrà essere un flemmatico con un carattere più chiuso e così via, per provare tutte le sfaccettature dell’umano. Mai un’individualità s’incarnerà con l’intento di ripetere quel che ha già attraversato e acquisito in esistenze già trascorse. Anzi, una delle cose cui Steiner accenna è quella di prestare attenzione alle persone che c’infastidiscono, che ci irritano, perché queste potrebbero facilmente rammentarci, in modo inconscio, la personalità che eravamo noi stessi nella vita trascorsa.
In questo incarnarsi in una corporeità ogni volta diversa, in fondo c’è anche una spiegazione dell’immortalità. A questo proposito consentitemi un paragone (forse non proprio felice, ma è per intenderci): se io sono il conducente di una macchina che guido da anni e questa macchina, nonostante io abbia cercato di mantenerla in buono stato, arriva ad un punto da essere proprio scassata, devo provvedere alla rottamazione. Ora, non è che rottamando l’automobile bisogna rottamare anche il conducente! Facendo le dovute proporzioni tra la straordinaria bellezza della corporeità, che certamente non ha nulla a che vedere con quello strumento solo meccanico che è l’automobile (però un minimo di analogia c’è), sta di fatto che la nostra cultura materialistica pretenderebbe di rottamarci tutti al cimitero insieme ai nostri corpi, quando questi non saranno più in grado di condurci da nessuna parte.
Da questa prospettiva di più e più vite si perviene a un altro pilastro di questa nuova scienza dell’uomo: quello del karma o destino. Perché la propria esistenza abbia un senso e non sia una beffa, una trappola, una presa in giro (a Roma direbbero: una gran fregatura), ciò che non può mancare è la serietà delle conseguenze di quello che in una vita ognuno di noi compie. Bisogna che ci sia, per esempio, per una persona che per tutta la vita ha lottato verso una meta magari senza raggiungerla, la sicurezza che con la sua morte non vadano a finire nel nulla la costanza ed il coraggio che ha mantenuto per decenni e decenni. Così anche, all’opposto, una serie di azioni malvagie rimaste nascoste devono prima o poi avere una conseguenza reale per chi le ha compiute, perché chi le ha subite le porta con sé nella sua vita — e nelle vite a venire. Il karma è questo ritornare di vita in vita, sull’individualità, sull’Io che s’incarna, delle conseguenze delle sue stesse azioni.
E chi è che prepara questo scenario — tanto per rimanere nell’immagine del teatro— di vita in vita? È il nostro stesso Io insieme, ci dice la scienza dello spirito, agli Esseri delle più alte Gerarchie spirituali. Serafini, Cherubini e Troni aiutano il singolo essere umano a far sì che nella vita che va nuovamente a cominciare non gli manchi nessun evento — e nessun incontro — per pareggiare o per promuovere qualcosa di nuovo nella sua vita, nel suo cammino evolutivo.
Nella vita nuova che comincia quando nasciamo, abbiamo già un karma che il nostro Io ben conosce e del quale è lieto. Il nostro Io superiore ardentemente vuole tutti gli eventi della sua vita, compresi quelli che alla nostra anima, al nostro io più piccolo, appariranno terribili e che magari maledirà dal primo all’ultimo. Il nostro Io superiore, invece, vuole questi eventi perché sono occasioni imprescindibili di avanzamento evolutivo. Con l’incarnazione, abbiamo detto, la coscienza vasta del nostro Io superiore, che è capace di abbracciare l’interezza della vita, si riduce e diventa la coscienza usuale che ben conosciamo, quella che riesce ad andare indietro, con maggiore o minore precisione, fino a quando avevamo due o tre anni d’età. La coscienza del nostro io normale risale fino al periodo infantile in cui abbiamo cominciato ad avere i primi ricordi, e procede così, giorno dopo giorno, senza essere capace d’intuire più di tanto il futuro e dimenticando anche molte cose del passato.
Ebbene, in tutto questo scenario, sono previsti, voluti e amati anche gl’incontri. Anzi, il primissimo incontro che facciamo, quello con i nostri genitori, è non solo voluto ma addirittura preparato con amorevolezza, con grande tensione e dedizione, già prima di nascere, fin dai mondi celesti, quelli nei quali viviamo tra un’incarnazione e l’altra. Per tutto il periodo in cui si prepara a ritornare sulla Terra, l’Io di ogni essere umano segue, di generazione in generazione, l’Io di colei che sarà sua madre, l’Io di colui che sarà suo padre, fino al momento del concepimento. Lo spirito che si vuole incarnare favorisce fortemente questo incontro e anche l’accensione del desiderio tra l’uomo e la donna. In realtà, l’ovulo fecondato dallo spermatozoo maschile, anziché complicare in maniera straordinaria la materia, non fa che caotizzarla. In quel frammento di materia che è l’ovulo femminile, grazie allo spermatozoo maschile viene annullata ogni specifica legge formativa legata alla fisicità del padre e della madre e lo spirito dell’essere che si vuole incarnare può così costruire, edificare, durante tutto il periodo embrionale, il proprio corpo «a sua immagine e somiglianza». Tutto questo avviene grazie allo spazio che la madre crea nella sua stessa corporeità e, prima ancora, grazie all’assenza di coscienza che caratterizza l’atto sessuale. Vedete che abbiamo un capovolgimento di prospettiva: non solo nessuno di noi nasce senza volerlo, ma tutti ci diamo un gran da fare perché i nostri genitori si incontrino e, a volte, questi incontri avvengono davvero in maniera rocambolesca.
Il primo ambiente che noi incontriamo è quello della famiglia, il luogo privilegiato per fare, da piccoli, le esperienze fondamentali. La prima è l’esperienza dell’amore, quella sorta di sicura accoglienza che passa quasi per osmosi attraverso il tatto, la voce, i movimenti della madre, in particolare, ma, ovviamente, anche del padre. È un tipo di esperienza di sicurezza che farebbe dire al bambino, se potesse parlare: queste braccia che mi accolgono sono buone, le pareti di questa casa mi ricevono e mi proteggono, questi esseri attorno a me hanno cura di me, provvedono ai miei bisogni, io sto tranquillo perché mamma e papà sono buoni, mamma e papà mi vogliono bene. Questa è l’esperienza inconscia che noi ci auguriamo ogni bambino possa fare perché ogni bambino nasce con questa speranza e con il diritto evolutivo di essere amato. Questa è la prima occasione d’esperienza che il legame più stretto — quello col padre e la madre — ci dà. Poi, crescendo, padre e madre si fanno autori di un’ulteriore occasione: quella di farci sperimentare la fiducia assoluta in un essere umano: «L’ha detto papà! L’ha detto mamma!».
Se sono un bambino piccolo e mi sta succedendo qualcosa di brutto, chi chiamo? Chiamo la mamma, chiamo il papà, perché pronunciando queste due paroline io sono assolutamente sicuro che sarò salvato, che sarò aiutato come nessun altro potrebbe mai aiutarmi. Che la famiglia possa offrire al bambino l’esperienza insostituibile della presenza dell’amore è quanto di più sperabile. Permettetemi una piccola parentesi che non vuole assolutamente essere una bacchettata per nessuno, visto che in questi tempi tutti abbiamo vissuto la realtà sociale della donna che lavora. E doveva essere vissuta. Ma c’è una sorta di ritornello che, per certi versi, io trovo un po’ squallido. Dice: «Io con mio figlio posso starci poco, ma del resto quel che importa è la qualità non la quantità». Eppure, al di là di ogni senso di colpa, che non serve a nulla, quello che conta per il bambino è proprio la quantità e non la sola qualità. Sarebbe come pretendere di alimentare qualcuno con due grammi al giorno di caviale di altissima qualità! Certo, i nostri figli sono cresciuti lo stesso, anche con noi mamme lavoratrici, ma il bambino ha bisogno della presenza fisica della madre, particolarmente nel primo settennio, e comunque ha bisogno di vivere in un ambiente famigliare. Noi ci siamo inventati gli asili perché i bambini devono «socializzare»: altra bugia tremendissima. I bambini socializzano benissimo col papà, la mamma, la nonna, la vicina di casa; socializzano andando a fare la spesa, con la mamma, al mercato, apparecchiando la tavola, pulendo i carciofi… Io ricorderò sempre quella mattina di tanti anni fa, in cui io ero un po’ «stranita», china a pulire i carciofi — ero anche un po’avvilita e silenziosa, quel giorno — e mio figlio (avrà avuto quattro anni, era lì seduto al tavolo vicino a me, trafficava con me, come al solito. Ad un certo punto mi guarda e mi fa: «Mamma, sei bella come una fata, una fata che pulisce i carciofi». Mi guardava con certi occhi… e da lì ho capito quanto fosse felice! Oppure mi ricordo quando lo mettevo a lavare i piatti con indosso una mantellina impermeabile rossa che lo faceva sembrare un pompiere: trafficava, schizzava, faceva dei disastri, però gli piaceva molto imparare a lavare i piatti.
Nell’antichità i bambini piccoli venivano lasciati in compagnia di qualcun altro che non fosse un parente stretto soltanto se si trattava del «data». Il data era un maestro, una persona di età avanzata che aveva la caratteristica di essere assolutamente imitabile. Una delle cose che noi adulti dovremmo sapere quando incontriamo un bambino — che sia nostro figlio o no non ha importanza — è che nel primo settennio i bambini sono dei totali imitatori. Delle tre forze dell’anima — pensare, sentire e volere — ciò che in loro è preminente è la volontà, che si esprime essenzialmente nel movimento. I bambini sono degli imitatori incredibili e dunque colui che si muove accanto al bambino dovrebbe sapere che è importante essere imitabile non solo per quello che fa esteriormente, per i gesti che dovrebbero essere sempre sensati ed estetici, ma anche per quello che vive e si muove nella sua interiorità. Un pensiero iroso, un sentimento d’odio per quanto taciuto e non espresso passa, per osmosi, al bambino. Queste sono conoscenze che un iniziato può percepire direttamente, e chi non lo è non è costretto né invitato a crederci. È invitato altresì ad osservare, ad aprire gli occhi. E a trarne conseguenze.
I nostri bambini — ogni madre lo sa — si accorgono quando diciamo una bugia, loro lo sanno. I bambini si accorgono quando qualcuno gli si avvicina con un sorriso falso, i bambini distinguono subito chi li ama, chi ha davvero piacere a stare con loro e chi, invece, non è mosso da gioia genuina mentre gioca con loro. Il bambino non solo è capace di imitare quello che vede, ma la sua anima esposta, assorbente come una spugna, s’imbeve anche delle movenze dell’anima attraversate dai pensieri di chi sta loro accanto. Pensiamo dunque alla responsabilità che abbiamo verso i bambini e nello stesso tempo a quanto possiamo fare per loro: attendere con gioia il bambino che rientra dalla scuola, preparargli il pranzo con amore. È tutta salute per lui. In oriente è rimasta l’abitudine, andando a lavorare, di portarsi da casa il pentolino con il pranzo cucinato dalla persona che ci ama perché si sa che sono di tutt’altra benefica qualità le forze che entrano in un cibo preparato da chi, con dedizione, sta pensando a colui che se ne nutrirà. Avete mai fatto caso a quanto rimanga sullo stomaco una pietanza cucinata controvoglia? Fateci caso. Vi è mai capitato di svegliarvi alla mattina e di avere ancora la cena sullo stomaco? Chiediamoci come sia stata cucinata. Non che sia sempre così, è ovvio; però capita molte volte. Sottilmente, i rapporti tra gli esseri umani penetrano fin nella corporeità.
Tornando al tema degli incontri, nel secondo settennio, dai sette ai quattordici anni, i bambini generalmente cominciano ad avere un primo assaggio importante dei rapporti non di sangue. E chi è l’essere umano più significativo che si affaccia nella loro vita e che, solitamente, è il primo a presentargli il resto del mondo, quel mondo che sta fuori dalla porta di casa? È il maestro. O la maestra. Pensate a quale responsabilità bellissima abbiamo noi maestri. Siamo coloro che presentano ai bambini gli altri esseri umani e facciamo gli onori di casa dell’intero universo. C’è un unico modo perché questo sia realmente possibile: esercitare una pedagogia davvero umana. Chi si è interessato di pedagogia «steineriana» — che io non amo chiamare così perché sembra una cosetta alternativa per poca gente — sa che l’arte dell’insegnamento che nasce dalla moderna scienza dello spirito è profondamente umana, è cioè pensata e creata dall’uomo e per l’uomo, e ha carattere mondiale. Questo noi dovremmo avere come certezza interiore, e ci infonderà coraggio. Noi, dico, che auspichiamo che una tale pedagogia possa diffondersi nel mondo. Pensiamo a quei figli che sono andati a scegliersi proprio quei genitori che poi li hanno portati a frequentare la scuola steineriana… Un Io che s’incarna e vuole frequentare una scuola davvero umana si va a cercare quei genitori che saranno così spregiudicati e, per certi versi, così pazzi da andarla a cercare all’altro capo della città perché, di solito, la scuola steineriana non è mai sotto casa! Quasi nessuno si trova ad abitare con una scuola così nel quartiere: questo non fa quasi mai parte del karma, perché questa pedagogia comporta sempre un karma di grandi fatiche! E noi insegnanti dobbiamo avere il coraggio di non sentirci persone che vanno elemosinando un posticino nel mondo della scuola, che bussano al Ministero della Pubblica Istruzione per dire timidamente: «Ci siamo anche noi, facciamo proprio quello che fate voi… solo in modo diverso… dateci la parifica, per carità». È l’esatto contrario! Siamo i portatori fortunati di un dono straordinario per tutti i ragazzini di questo mondo ed è imprescindibile vivere interiormente questa consapevolezza, altrimenti, in Italia si rimarrà schiacciati da un secolo e passa di scuola statale organizzata in un certo modo, che però ha fatto il suo tempo, pur essendo stata la benvenuta in una nazione piena di analfabeti come eravamo poco più di un secolo fa.
Dicevo che il maestro è il grande cerimoniere dell’universo ed è anche colui che ci dà l’occasione di sperimentare la bellezza. Nel primo settennio i genitori ci danno la via di accesso al buono, nel secondo settennio, i primi anni di scuola ci danno l’occasione di incontrare la bellezza, l’armonia, la reciproca appartenenza fra noi esseri umani e fra noi e i regni di natura. I maestri sanno che non esiste una separazione reale fra tutti gli esseri del creato, sanno che ciò che spesso si vede disegnato sui libri per bambini è un’irrealtà, sanno che è mostruoso e falso disegnare, per esempio, un albero senza le radici, senza la Terra su cui poggia, senza l’aria, senza l’immagine del sole, dei suoi raggi, senza aver fatto sperimentare che il verde nasce dalle forze acquee della linfa che salgono e incontrano il giallo della luce… Questa è la verità degli esseri che sono collegati gli uni agli altri perché soltanto la fisicità, illusoriamente, ci divide, ma per le dimensioni non corporee della vita non c’è scissione tra gli esseri. Il maestro deve far capire e far sperimentare queste cose al bambino, attraverso immagini, le più creative possibili. E soprattutto deve aver davvero fatto proprie queste verità.
Il bambino dai sette ai quattordici anni, ricordiamocelo sempre, ha un’intelligenza del cuore, non ha un intelletto critico. Critico viene dal greco ‘crìsis’ che vuol dire separazione, il crinale che separa l’un versante dall’altro. La crisi, la critica, appartengono al terzo settennio, non al secondo. E la sollecitazione precoce dell’intelletto critico è un danno alle forze creative, alle stesse forze di crescita e salute dei nostri figli. L’esperienza della bellezza e della reciproca appartenenza inconsciamente preparano, in quello che sarà l’adulto di domani, il senso della giustizia, il senso della pari dignità di tutti gli esseri del mondo. E, allo stesso modo, ancora più inconsciamente, nel primo settennio, tramite questa immersione nell’amore che soddisfa tutte le tue esigenze di bambino, tutti i tuoi bisogni, che lenisce tutte le tue pene, si sperimenta quella che da adulti chiameremo la fratellanza. Per chi non lo sapesse, Steiner, nei suoi scritti sulla questione sociale, mette la fratellanza alla base della vita economica. Allo stesso modo egli mette il senso della pari dignità, della reciproca appartenenza, nelle forze del sentimento che, negli adulti, si tramuteranno in capacità di giustizia sociale — infatti, come il primo settennio di vita è tutto impregnato di volontà, il secondo settennio è prevalentemente sentimento.
Nel terzo settennio fra compagni di scuola — che sono gli ulteriori incontri non di sangue che cominciano ad entrare fortemente nella vita di ogni adolescente — si fa spazio una domanda fondamentale: come stanno le cose, nella vita e nel mondo? dov’è la verità? La responsabilità dell’insegnante delle classi superiori, che deve rispondere a queste domande, è enorme. Così come il bambino del secondo settennio vuole avere nel maestro una persona autorevole della quale potersi fidare come fosse il genitore, pur sapendo che non lo è, allo stesso modo il ragazzo della scuola superiore chiede al professore una conoscenza specifica, specialistica, delle materie. Voi sapete che nelle scuole «steineriane» ai maestri di classe non è richiesta la laurea perché dovrebbero sapersi cimentare in tutte le materie, dovrebbero poter insegnare ogni disciplina dalla prima alla settima classe. Io, fin dai tempi in cui facevo parte della Federazione delle Scuole Waldorf in Italia, insistevo perché il maestro insegnasse le varie materie dalla prima alla settima classe anche se, di solito, si parlava di insegnamento dalla prima all’ottava classe. Non so se le cose stiano oggi ancora così ma spero che siano cambiate. Siccome Steiner era una persona pratica aveva inserito l’ottava classe, una in più oltre la settima, perché, nella Germania di allora, come in Italia del resto, il percorso di studi prevedeva otto anni obbligatori. Ma era così una volta. Nella scuola di oggi (a maggior ragione dopo questa specie di riforma che è stata fatta ad hoc per adeguarci ai dodici anni complessivi di insegnamento che vigono in Europa) non solo dobbiamo approfittare del fatto di adeguarci ai sette anni del primo ciclo, ma sarebbe stato auspicabile che ogni insegnante di scuola Waldorf, semplicemente per pura conoscenza antropologica, si fosse reso conto che l’ottava classe era un semplice stiracchiamento e che in realtà si sarebbe dovuto, in quella classe, insegnare come in una prima superiore. E infatti in ottava classe cominciano sempre i guai perché lì è veramente necessario l’esperto, e allora in tante scuole c’è stato un rendersi consapevoli dell’esigenza assoluta di avere insegnanti laureati. Cosa significa la laurea? Significa specializzazione — e il ragazzo dai 14 ai 21 anni chiede che chi si pone come professore sappia profondissimamente ciò di cui sta parlando. Anzi, cerca proprio di saggiarne le capacità, all’occorrenza cerca di prenderlo in castagna. I ragazzi vogliono poter stimare il loro professore, non hanno bisogno di fidarsi incondizionatamente, come facevano col maestro, ma vogliono poterlo apprezzare e rispettare. Il professore approssimativo nella scuola superiore è fuori luogo come il maestro elementare che voglia fare il genitore — cosa che non va bene, perché non lo è. Il maestro che porta i ragazzini a dormire in casa propria, tanto per fare un esempio, che li tratta e interloquisce con loro come fosse un genitore (e crede così, forse, di essere un insegnante «diverso», «moderno», «buono») esce dal ruolo che gli compete.
Riflettiamo su questo: il bambino chiede all’adulto che è il suo maestro di essere autorevole, e si aspetta da lui tutt’altre cose di quelle che gli vengono dai suoi genitori.
Apro una parentesi su un altro modernissimo guaio nei rapporti di sangue: i genitori che vogliono essere amici dei propri figli, impropriamente amici. Lì per lì magari i nostri figli possono anche essere contenti ma quando saranno grandi ci rimprovereranno di questo. I nostri figli, pur non sapendolo, non vogliono un genitore amico, non vogliono un genitore che si ponga al loro livello e parli dei suoi affari. Ho conosciuto, ho avuto in classe allievi che avevano sulle spalle, tanto da assumere una postura ricurva, il peso di drammi familiari. Succedeva che ora l’uno e ora l’altro genitore andasse a raccontare al figlio di 13/14 anni le problematiche, poniamo, di una separazione o le emozioni di un incontro con un nuovo compagno. Questi sono errori. In una vita, di errori se ne fanno tanti e quindi non è che ci si debba fustigare. Imparare ad ascoltare che cosa ci chiedono i figli, che cosa ci chiedono gli alunni, fa però parte della capacità di amare perché si comprendono le esigenze dell’altro solo amandolo.
Nel terzo settennio, dicevo, c’è l’incontro con la verità delle cose, c’è l’incontro con ciò che dà la forza di sperimentare l’affacciarsi della libertà, c’è l’incontro con il pensiero. Ecco, adesso c’è anche la capacità critica, la capacità di cernita e divisione, c’è l’analisi, e tutto ciò consente anche il sorgere delle prime avvisaglie delle doti, dei talenti individuali: è questo il periodo nel quale si forma il terzo elemento sociale, che è appunto quello della libertà e delle capacità, quello che noi chiamiamo, grosso modo, l’ambito della cultura, quel mondo di professionalità lavorativa dove ognuno ha qualcosa di unico da portare agli altri. Il mondo della libertà e dell’autonomia, della sovranità del proprio lavoro — qualunque esso sia —, e che non ha nulla a che fare con quell’uguaglianza che, dicevo prima, nasce dalla reciproca appartenenza, dalla pari dignità umana. Nessuno nel lavoro è uguale all’altro, ci mancherebbe. Qui non c’entra l’uguaglianza, come non c’entra niente la fraternità nel momento in cui si valuta ciò che una persona sa fare. Non m’interessa di volerti bene: se questa cosa non la sai fare, te lo dico. E non è vero che gli esseri umani siano tutti uguali, tout court: c’è chi è più bravo e chi è meno bravo, chi è più avanti e chi è più indietro nei campi più disparati. Ma tutti gli uomini sono ugualmente degni di essere dove sono e come sono, per il semplice fatto che sono come sono, e ne hanno tutto il diritto. Lo so che quel che dico è quasi come riscoprire l’acqua calda… ma quest’acqua è calda solo se l’amore la riscalda, e noi, invece, andiamo avanti ad acqua fredda. Solo l’amore sa capire che, per ogni persona che incontriamo, la cosa più assurda è pretenderla diversa da come è.
Ma lasciamo da parte, per ora, tutti i risvolti della vita sociale ed arriviamo al punto in cui, ormai superato il terzo settennio, l’Io, lo spirito, è in grado di emanciparsi e di agire in libertà. L’essere umano è maggiorenne e lo si vede anche da come cammina. Quando l’Io «discende» nei suoi involucri fisico e animico, il ragazzo poggia sui talloni diversamente, l’andatura un po’ dinoccolata e ciondolona dell’adolescente, che sbatte dappertutto ed è sempre pieno di lividi, ad un certo punto prende una sua dirittura che quasi ripete, al livello spirituale, appunto, il momento in cui vedemmo i nostri figli, intorno al primo anno d’età, ergersi e imparare a camminare. Attorno ai 20/21 anni gli esseri umani si ergono un’altra volta ed è bellissimo per noi adulti avere la fortuna di osservali. O meglio, di accorgersene. Ecco allora che il ragazzo entra vigorosamente nella vita e cominciano alla grande gli incontri elettivi, quelli che non hanno a che fare con la parentela di sangue. Nel vangelo c’è una frase che ha veramente dato grandi pene agli esegeti, in cui il Cristo dice: «Se uno viene a me e non odia (questa è la traduzione vera, il verbo greco misèin significa odiare, contrapporsi duramente) il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, i figli e la propria stessa vita (la propria personalità, l’elemento animico egoistico) non può essere mio discepolo». Cioè non può essere discepolo dell’Io. Ogni volta che il Cristo si riferisce a sé, ogni volta che, per esempio, dice «mio», se voi lo traducete con le parole «dell’Io» potete coglierne il significato più profondo. Il nome esoterico del Cristo è «Io Sono», come sempre è ripetuto nel vangelo di Giovanni. Cristo è l’Essere che in Terra opera e pensa sempre come un Io spirituale incarnato. Qui è svelato il mistero dei rapporti umani, dei rapporti elettivi. Bisogna uscire dalla dimensione del clan, del sangue, dell’autoriferimento ristretto e privilegiato a chi ci è simile nella discendenza corporea per aprirsi alla comunità umana non automatica, cioè quella che riguarda le dimensioni dell’anima e dello spirito. Quello sarà il momento in cui cominceremo ad incontrare in piena coscienza (e non pensando che sia un caso!) coloro che il nostro karma vuol farci incontrare attivando le nostre forze di libertà. Ai legami genetici e di tradizione si affiancano e diventano sempre più importanti i rapporti voluti liberamente, quelli che vanno creati e sostenuti senza l’appoggio della parentela.
La scienza dello spirito descrive due caratteristiche dell’incontro che ci fanno capire se le persone che compaiono nella nostra vita sono vecchie conoscenze di vite passate oppure sono individualità mai incontrate prima. È evidente che, di vita in vita, i rapporti aumentano, mica diminuiscono; noi non incontriamo sempre e solo le stesse persone. Pensiamo a cosa significhi aver inventato strumenti come i media (televisione, radio, telefono): in un battito di tempo, milioni di persone hanno modo di avere una prima notizia del personaggio X o del personaggio Y…
Comunque, ci sono delle persone che sono vecchi compagni di strada ed altre che sono nuove conoscenze. I vecchi compagni di strada si riconoscono dal fatto che al primo incontro li sentiamo subito simpatici o antipatici e ingenerano, oltre a questa sorta di emozione, anche una spinta attiva, coinvolgono la nostra volontà. Noi vogliamo entrare in una relazione di vita con queste persone, nel bene o nel male. Invece un nuovo acquisto nel nostro cammino è una persona che noi incontriamo in maniera spassionata e nei confronti della quale ci poniamo essenzialmente con il pensiero, con il giudizio. La osserviamo, la ascoltiamo, magari non è detto che la frequenteremo chissà quanto, stiamo attenti al suo essere, non siamo emozionati e coinvolti, riusciamo a far fare un passo indietro a noi stessi per far spazio alla conoscenza dell’altro. Voi sapete bene che per comprendere realmente quello che un altro sta dicendo bisogna, in un certo senso, addormentare il proprio dire egoistico, la propria ipertrofia, e lasciare agire la parola dell’altro — sennò non capiamo nulla, chiudiamo le tende, come si suol dire. Detto questo, quasi quasi sembrerebbe che i vecchi incontri siano quelli un po’ più complicati, quelli che in realtà non ci trovano così generosi. Infatti un’emozionalità nell’incontro, parliamo essenzialmente del primo incontro, ci racconta profondamente di noi stessi, non dell’altra persona. L’incontro nuovo, che noi spassionatamente attraversiamo, ci permette invece di incontrare l’altro così com’è. Nel primo caso noi ci viviamo così come nelle trascorse vite ci siamo posti in relazione a questa persona, con tutto ciò che abbiamo causato nella sua interiorità. L’esempio più classico è l’innamoramento, il colpo di fulmine che inizialmente racconta che cosa reciprocamente si è stati l’uno per l’altro. Ma in realtà io vedo me non l’altro. Sono io ad accendermi, ho un’autopercezione, un’autotastazione straordinariamente beatificante; l’innamoramento è la summa dell’egoismo, di un bellissimo egoismo certamente, e c’è da augurarlo a tutti i giovani perché aiuta a conoscersi. In fondo, l’innamoramento che abbraccia l’anima ha per l’anima la stessa funzione che avevano le fasce per il corpo — sì, quelle preziose fasce che non vanno più di moda e in cui venivano avvolti i neonati, quel primo contenimento importantissimo, il primo modo per sentire la propria unicità, ma anche il proprio limite. (L’altro grande limite, di cui mi sono dimenticata di parlare, sono tutti i «no» che i genitori sanno dire ai figli con vera fermezza. Niente tempra e rafforza la volontà più del trovare ostacoli che frenano la facile irruenza e allenano la coscienza).
L’innamoramento, dicevo, ti fa esplodere un’enorme carica amorosa verso te stesso, senti di volerti tanto bene, hai proprio un’accensione di te stesso…e siccome quest’accensione aumenta quando vedi l’altro, tu pensi di amare lui ma, in realtà, ami le emozioni che l’altro ti fa provare e son quelle che vuoi e rivuoi. È come volersi rendere sovrani di uno stesso regno (cosa impossibile!) in cui tu dai lo scettro a lui, lui lo dà a te e questo stato idilliaco e sognante dura quel che dura, dopodiché si arriva ai conti veri. E, solitamente, più è complesso, importante, difficile e forse anche doloroso quello che c’è karmicamente da fare con quella persona e più l’incontro viene «infiocchettato» nel karma in modo che l’io inferiore, che solitamente scappa di fronte alle difficoltà, ci caschi con entrambe le scarpe! Negli eventi così travolgenti delle grandi passioni e degli innamoramenti c’è una chiara e sapientissima regia dell’Io superiore. Se andassimo a vedere come vanno a finire tante relazioni iniziate con un grande innamoramento e che poi si incagliano in grosse difficoltà diremmo: «Se non ci fosse stato quell’iniziale veder tutto rosa e d’oro, mai e poi mai io mi sarei messo in una situazione di così stretta relazione con te».
Faccio qualche altra considerazione sulla qualità degli incontri. Quando noi vediamo che l’altro ci porta incontro le sue capacità, quello che a noi piace tanto di lui, dovremmo capire che, karmicamente, quello che ci sta venendo incontro di questa persona è un debito che essa ha contratto con noi. Se questa persona, per esempio, conosce l’inglese ed altre lingue molto bene ed io ammiro questa sua capacità, probabilmente lei me le insegnerà, o mi sarà d’aiuto proprio grazie a queste sue specifiche conoscenze. È un musicista? Mi piace tanto starlo a sentire? Ebbene, questa persona mi riempirà la vita di musica perché io ho proprio bisogno di questo per la mia evoluzione, perché questo mi manca. E fin qui tutto bene perché queste sono le abbondanze positive, sono i doni. Ma come la mettiamo con le manchevolezze? Come la mettiamo con i difetti (dal latino deficere, mancare)? I difetti, miei cari, sono tutti crediti dell’altro. Vi è mai capitato di dire: «Quella persona riesce, e solo lei ci riesce, a scatenare il peggio di me!». Oppure capita che puntiamo il dito: «Questa persona è violenta, falsa, bugiarda, invidiosa!». Questa è una situazione di credito in cui l’altro ci viene incontro con la sua lacuna. E viene incontro a me, non ad un altro perché proprio io ho di che colmare questo suo vuoto. Altrimenti andrebbe da qualcun altro. Sarebbe bello capovolgere la prospettiva e capire che quella persona vorrebbe il meglio di noi, non il peggio. Chi ci provoca vuole da noi quello che gli manca, così come noi — e tante volte ce ne accorgiamo pure —, quando magari siamo violenti con qualcuno, è che proprio da quella persona vorremmo quello che ci manca. Dolcezza, amore. È un’altra scoperta dell’acqua calda, questa, ma per scoprirla e scaldarla, quest’acqua, ci vuole amore.
Devo spendere due parole sull’amore. L’amore somiglia molto poco a quello che noi solitamente intendiamo, come dicevo la volta scorsa. Quando noi diciamo: «Ti voglio bene» intendiamo: «Sii mio». Il gesto è quello di afferrare, di portare a sé, di possedere e avere. Il gesto dell’amore vero è invece quello del tirarsi indietro per far spazio alla libertà dell’altro ed essere felici mentre lo si fa. L’azione d’amore non va a parare a nulla d’altro, non vuole un ritorno, non gliene importa nulla, è felice di per sé, non ricatta mai, non misura, non sa fare i conti, l’amore non è un ragioniere, l’amore sbaglia sempre in eccesso. E soprattutto, l’amore non fa paragoni, non dice: «Tu saresti meglio se fossi così». La mania che noi abbiamo di criticare, o peggio di emanare giudizi morali sugli altri, è causa dei tanti piccoli-grandi omicidi che noi perpetriamo l’un l’altro. Giudicare come negativa l’azione di una persona significa che noi cancelleremmo volentieri dalla faccia della Terra quel suo momento di vita. Oppure significa che riteniamo che, mettendoci nei suoi panni, noi avremmo fatto di gran lunga meglio. Ma questo è impossibile, l’abbiamo detto mille volte, perché se noi ci mettessimo veramente nei panni di un altro avremmo dietro di noi tutta la sua storia, tutta la sua vicenda, avremmo i suoi pensieri, i suoi sentimenti, le sue spinte volitive e faremmo esattamente quello che ha fatto lui, senza una virgola di differenza. L’amore è quella stessa esperienza di accoglienza totale e incondizionata che da piccoli ci auguriamo tutti di aver fatto fra le braccia dei nostri genitori,. L’amore è accoglienza pura. E pensate cosa vuol dire riuscire a viverlo, a crearlo fra adulti. Tutto sommato è facile prendere tra le braccia, senza condizioni e con la più grande disponibilità, una creatura piccola… ma con un adulto è difficile, tanto più se questo non ci ama, non ci ricambia, non mostra nemmeno un accenno di quel sorriso beato che perlomeno ogni bambino, seppure ignaro del perché, ci regala. Eppure l’amore è questo. È gratuità pura.
Un’altra delle cose che vorrei aggiungere, ed a cui dobbiamo prestare sempre attenzione negli incontri, è che la persona che ci sta di fronte non sia mai vista come strumento ma sempre come fine. La nostra è una cultura strumentale e utilitaristica, noi siamo abituati ad osservare le cose del mondo chiedendoci sempre a che cosa ci servono, che cosa ce ne possiamo fare. Senza rendercene del tutto conto, diciamo la stessa cosa per gli esseri umani. Molte volte noi li usiamo e questa è la negazione dell’incontro, perché l’incontro vero è quello che si fa tra spirito e spirito. È l’anima che usa, è l’anima che ama personare, risuonare, riferire tutto a se stessa chiudendosi nell’autogodimento degli affari suoi. Lo spirito è compenetrazione degli uni negli altri. Lo spirito guarda all’altro come ad un sovrano. Nell’incontro con lo spirito dell’altro, il mio spirito (se fosse davvero presente nella sua pienezza) si muoverebbe come se stesse celebrando un culto, come se stesse operando un sacramento. Questa è la religione del futuro. Steiner lo dice più volte: la religione del futuro è l’incontro fra essere umano ed essere umano. Il divino non lo incontro più in un luogo specifico, in una chiesa o in un tempio: lo incontro nell’altro. Il Cristo dice: «Quando due s’incontreranno nel mio nome (nel nome dell’Io, da Io a Io) Io sarò lì (l’Io Sono, la forza divina dell’uomo sarà lì)».
Questa è la straordinaria serietà e importanza evolutiva degli incontri. Gli incontri sono scambi, sono promozioni evolutive che un essere umano dà all’altro. Ma ci sono anche le ostilità. Mi sono dilungata troppo sul resto e ora dovrò stringere sulla questione degli scontri fra esseri umani. In fondo, odiare una persona è pur sempre un modo di tendere fortemente a lei. C’è una sequela interessantissima che Steiner indica, a cui accenno appena perché ho chiacchierato troppo. Le persone cui siamo stati capaci di dare amore, nella vita successiva, quando ci verranno incontro, saranno per noi fonte di gioia. E non perché si metteranno in testa di farci felici, ma perché saranno quelle persone che al solo apparire ci rallegrano il cuore o che, magari, ci risolveranno delle situazioni. Sono le persone delle quali diciamo: «Che Dio ti benedica, tu nella mia vita sei una benedizione, mi porti gioia». Queste sono persone che in una vita precedente noi abbiamo amato veramente. E in una terza incarnazione la persona che ha prima amato, poi ricevuto occasioni di gioia — essere gioiosi nella vita è una gran bella cosa! —, che si è rallegrata non come un’oca giuliva ma che ha attivamente fatto festa all’incontro, avrà in una terza incarnazione una mente aperta. La mente aperta significa capacità pensante, significa un’attività del pensare capace di star dietro spregiudicatamente alla logica dell’amore che costruisce il mondo. Il pensiero rigido non capisce nulla e non capisce il mondo.
Steiner ha poi indicato la sequela dell’odio. L’odio, dicevo, non è altro che l’estrema forma dell’egoismo, dell’amore di sé distorto e monco. Io odio una persona perché sento che mi destabilizza, sento che è un pericolo per me e io mi difendo. L’odio è quasi sempre una difesa, è sempre l’espressione del sentire una minaccia perché è difficile vivere davvero la reciproca appartenenza, l’essere gli uni per gli altri. Invidiare qualcuno, ad esempio, è volerlo ammazzare, è volerlo eliminare da quel suo ambito di vita, o di lavoro, che vorremmo fosse nostro. Odiare una persona può essere non rispettare i rapporti che ha. Come? Mettendo zizzania, per esempio. I rapporti che noi dobbiamo curare non sono solo i nostri, ci vuole anche il rispetto dei rapporti altrui.
Quanti rapporti fra le persone vengono rovinati perché terzi o quarti s’intromettono mossi da quell’astio peculiare che è dato dall’invidia. Ebbene, questo odio, nella vita successiva, tornerà incontro a queste persone sotto forma di dolore, di sofferenza. Non che le persone che sono state oggetto di odio nella vita precedente, nella vita successiva si mettano lì d’impegno per fargliela pagare. No, non è così. Queste persone che hanno ricevuto odio, pur senza volerlo saranno causa di sofferenza per l’altra persona. Per farvi un esempio: può capitare che questa persona s’innamori proprio di quell’individuo che nella vita precedente aveva odiato e quello non se la filerà per nulla, facendole patire l’inferno. Nella terza vita successiva, questa persona avrà una mente più ottusa, avrà un’incapacità di star dietro a quella che prima chiamavo «la logica mobile dell’amore».
La terza qualità degli incontri è quella all’insegna dell’indifferenza, e secondo me è la più terribile perché l’odio non è il contrario dell’amore. L’amore non ha contrari, il contrario dell’amore è solo l’assenza dell’amore. Apro una parentesi: tutta l’opera omnia di Steiner contiene indicazioni sull’amore, ma ci terrei a segnalarvi caldamente due libri di Pietro Archiati: Il mistero dell’amore e L’arte dell’incontro. Le tante cose che dice Steiner sulle questioni del karma, dell’amore e così via, in questi due libri vengono affrontate in un modo innovativo, proprio in nome del fatto che la scienza dello spirito è una materia che va elaborata da tutti noi. Così come gli scienziati non si sono fermati a dire: «Galilei ha detto» ma hanno, nel tempo, continuato ad andare avanti e a progredire nelle questioni scientifiche, allo stesso modo, ognuno di noi deve diventare scienziato dello spirito, senza campare eternamente di rendita sulle spalle di Steiner. Per questa ragione, io amo indicare le opere di chi ha qualcosa di originale da dire e quindi vi segnalo caldamente questi due libri. Chiusa parentesi.
La più terribile delle situazioni, dicevo, è quella dell’indifferenza. È tipica delle persone che nella vita agiscono e si relazionano essenzialmente sulla corda del dovere. Il dovere parla così: mi rivolgo a te con rispetto perché mi sei madre e te lo devo. Faccio bene il mio lavoro per dovere…
Una persona che faccia tutto o comunque compia la maggior parte dei gesti della vita per senso del dovere, nella vita successiva riceverà, da chi gli viene incontro, disamore, indifferenza rafforzata. Non so se vi sono mai capitate persone che vivono come fossero trasparenti, che dicono: «Ma come, io ero lì e non mi hai visto?». Oppure quelle persone che in una comunità, o in un gruppo di lavoro, non vengono mai interpellate, non vengono mai considerate, sono trasparenti, suscitano il nulla d’amore, l’indifferenza. Nella terza vita, questa stessa persona, avrà un’incapacità di interessarsi agli esseri e alle cose, condurrà una vita a casaccio, non avrà né arte né parte, non riuscirà mai a capire che cosa vuole fare da grande, rimarrà un’eterna indecisa, senza nerbo, una persona tentennante incapace di vero interessamento. E questo è più terribile dell’odio perché l’odio è comunque un fortissimo interessamento verso una persona. Dall’odio, se nella seconda vita la persona vive il dolore in modo sano, non è detto che nella terza vita scaturisca necessariamente l’ottusità. Solo se il dolore viene soltanto subìto, solo se non c’è una reazione dell’Io libero che volge il male in bene, si arriva all’ottusità. La cosa più triste è l’immobilità, è il fare qualcosa senza impulso proprio, per dovere, per consuetudine, per leggi esterne, per un pulpito interiore — così si fa, così si deve fare. Questa immobilità ingenera indifferenza e ingenera, in terza battuta, disamore verso il mondo.
Spero di avervi dato un’idea, seppure un po’ volante, di quanto si cela nei misteri degli incontri tra gli esseri umani. E visto l’argomento dell’incontro, mi piace ricordare che tante volte Steiner concludeva le sue conferenze, quando le teneva in luoghi diversi dal suo luogo di residenza, dicendo: «Noi ci salutiamo, ci separiamo soltanto fisicamente nello spazio perché la materia è esclusiva per natura e se io sono là non posso essere qua. Ma rimarremo uniti nello spirito».
L’augurio più bello che noi possiamo reciprocamente farci è davvero quello di rimanere uniti nell’anima e nello spirito, anche restando lontani perché lo spirito non ha tempo, non ha spazio. S’incarna nel tempo e nello spazio ma è sovrano del tempo e dello spazio. Vi saluto così, e spero che questo incontro sia stato oggettivamente buono. Per me senz’altro lo è. Se c’è qualcosa che vogliamo ancora dirci, bene… altrimenti un caro saluto a tutti.
Domanda. Lei ha fatto una distinzione tra spirito, Io superiore e anima cosciente. Come intende l’anima cosciente?
Carosi. Giusto la volta scorsa avevamo fatto la descrizione dell’anima, delle tre forme dell’anima: senziente, razionale e cosciente. Potremmo dire che c’è in ognuno di noi (nelle proporzioni più diverse) un’anima emotiva, istintuale, legata ai sensi fisici, potentemente reattiva e volitiva; che c’è un’anima affettiva, cioè desiderosa di capire e sentire, diciamo così, il fondamento, l’idea formativa che è alla base degli esseri e delle cose. Infine c’è l’anima cosciente, quella dimensione dell’anima che riesce ad oggettivare se stessa, quella forza dell’anima capace di aprirsi allo spirito, di aprire quell’unica porta verso l’alto — uso un’immagine spaziale — che permette ciò che nelle fiabe sono «le nozze» tra il principe e la principessa. Perché questo è. L’anima cerca il suo sposo sempre, cerca lo spirito. E quest’anima è sempre minacciata da qualche drago, da qualche strega, da qualche essere che vuole afferrarla e imprigionarla (agendo essenzialmente sull’anima senziente). Questo nella fiaba sta ad indicare il determinismo di natura, tutto ciò che ci determina, che ci automatizza, che ci rende schiavi di una situazione contingente, che ci riduce ad essere quello che fra 10, 20, 30, 40, 50 anni non saremo più perché questo corpo non lo avremo più. Tutto questo è l’orco che tiene prigioniera la principessa. Quando invece la principessa si accorge di cercare ardentemente una dimensione eterna, libera, sovrana, capace di autodeterminazione e di creatività, significa che si è innamorata dello spirito. E non dello spirito di qualcun altro ma del suo spirito, del suo amato, del suo vero principe e sposo. Del suo stesso essere divino, scevro di ogni egoismo.
Questo è il cammino della libertà: comincia nell’anima cosciente che s’innamora dello spirito, uno spirito che non sta per aria. Così, a chiunque creda di vedere nel karma e nella storia dell’umanità una specie di fatalismo islamico, o di luterana predestinazione, si può indicare nel cammino dell’anima cosciente il procedere sempre più autonomo dell’uomo verso la realizzazione intera di sé. La bellezza, la modernità, l’audacia della scienza dello spirito stanno nel riconsegnare all’uomo, alla dimensione umana, al figlio dell’uomo, come dicono i vangeli — e non all’eterno figlio del Padre che non si emancipa mai, che non abbandona mai la casa e la guida paterna — la possibilità e la responsabilità di accedere al divino. Perché il divino non è altrove, il divino è qui, in tutte le cose, e si annuncia nell’esperienza della libertà. E la prima attività dello spirito, quella più a portata di mano, è il pensare, soprattutto quando — magari nell’esercizio di meditazione che è il pane dell’anima cosciente — riusciamo a elaborare e condurre dei pensieri che non sono suscitati e impulsati dal mondo dei sensi e delle percezioni. È un pensare che non ha bisogno di spinte e, in fondo, tutta la scienza della realtà spirituale — Steiner lo dice a proposito del suo libro La filosofia della libertà — è l’esercizio continuo di un’attività pensante che si sostiene da sé, un’attività dove l’essere umano ha la prova provata della propria stessa individualità autonoma, ha l’esperienza di tenersi, di afferrarsi per il codino come voleva fare il barone di Munchausen, senza aver bisogno di un ulteriore appoggio. Tutte le cose del mondo, per noi, sono percezioni, i miei stessi sentimenti se io non li penso non so che cosa siano, le mie stesse decisioni volitive se non le penso non so che cosa vogliano. Soltanto l’attività del pensare non si presenta a me in due momenti distinti, non mi viene incontro per farsi dare un nome: la vivo la percepisco e la conosco contemporaneamente, mentre penso. Questa è l’esperienza divina che l’anima cosciente può fare. L’Io autosciente è il primo modo in cui, nell’universo, si manifesta lo spirito. L’Io è lo spirito più piccolo, potremmo dire, l’ultimo nato della Divinità. Noi siamo gli ultimi nati, il nostro Io umano è l’infante più amato dell’universo e l’anima cosciente è in grado di capirlo.
Domanda. Durante un ritiro spirituale di buddisti scoprii che nella tradizione buddista c’è un rituale di purificazione del karma, che è una specie di confessione. Uno va da un superiore e può, confessando, riaprire una pagina bianca. Mi ha molto colpito, non sapevo che nella tradizione buddista ci fosse qualcosa di analogo al rituale della riconciliazione… è una realtà simile al sacramento della nostra confessione cristiana. Volevo chiedere qualcosa riguardo a questo, in relazione alla legge del karma.
Carosi. Caratteristica del buddismo è quella di considerare l’incarnazione una vera prigionia per l’anima umana che torna sulla Terra solo perché spinta dalla brama d’incarnazione, dal desiderio di rientrare nel mondo dei sensi terreni che, pur essendo una maya (cioè una realtà illusoria che non ha, di per sé, consistenza in quanto perisce col tempo), agisce potentemente come una calamita. Il buddismo — perlomeno il buddismo ortodosso perché quello moderno molto ha acquisito dell’evento cristico che si è verificato per tutti e si offre a tutti: al musulmano, al buddista, all’induista… L’idea che solo il cristiano abbia il filo diretto con il sacrificio del Cristo e con tutte le sue conseguenze è, ad essere teneri, patetico — nel buddismo ortodosso, dicevo c’era la meta della purificazione, cioè del creare un distacco da tutto ciò che ci lega alla vita dei sensi terreni.
Probabilmente questo esercizio a cui tu accenni sarà un modo per tentare un abbattimento delle brame e favorire il distacco dell’anima dalla Terra. Invece l’evento cristico è amore per l’incarnazione, è un sancire la sensatezza e la divina importanza dello spirito che entra nella materia. Qui non c’è la «fuga mundi» tipica di ogni orientalismo (e anche di un certo cattolicesimo un po’ moraleggiante e bacchettante, che ha molte somiglianze con il buddismo). L’atteggiamento interiore precristico persiste dove non c’è la gioia per il cimento della vita, perfino la gioia dell’errore — se non si sbaglia non s’impara nemmeno —, persiste dove non c’è la gioia della caduta (del peccato originale, cioè) perché soltanto se si cade ci si può rialzare: se non cadi mai significa quantomeno che sei portato da qualcun altro più forte e potente di te. In fondo, il cosiddetto peccato originale non è un peccato morale dell’umanità: un’umanità che non aveva ancora la forza dell’Io, quella forza che poi sarebbe stata portata dal Cristo, ditemi voi che responsabilità poteva mai avere in quelle vicende del paradiso terrestre. Il peccato originale dell’umanità è piuttosto una caduta della coscienza, è una caduta intellettuale, è un offuscamento delle forze conoscitive che, dovendo esprimersi entro i limiti funzionali della corporeità, come prima conseguenza hanno comportato l’illusione che il mondo sia fatto di tante parti, che ci sia un fuori e un dentro, un sopra e un sotto, un mio e un tuo, e così via. Colui che ha tessuto in maniera geniale il linguaggio adatto alla logica caduta, alla logica della separazione e della individuazione dei nessi, è stato il grande Aristotele che ha reso dignità al pensiero «umanizzandolo». Partendo da questa logica che ormai tutti conosciamo e usiamo — in un certo senso siamo tutti aristotelici — dobbiamo ora progredire e fare un ulteriore passo per ridare vita alla logica diventata astratta e risalire alla sostanza, alla realtà vivente dei pensieri.
Concludo dicendo che in un libro bellissimo di Steiner dal titolo tremendissimo: Antroposofia, Psicosofia, pneumatosofia, il cui contenuto è straordinariamente bello, c’è un pensiero che dice più o meno: ‘noi non sappiamo più che cos’è la filosofia, non sappiamo più cosa sono i pensieri, meno che mai lo sanno i filosofi perché i pensieri sono oggi nient’altro che l’ombra, una ragnatela di ciò che per l’antica iniziazione era un incontro eterno’. Quando insegnavo facevo sempre ai miei alunni domande di questo genere [la relatrice fa alzare dalla sedia una persona del pubblico e la prende sottobraccio, NdT]: dite un po’, questo gesto che vedete come si esprime in grammatica? E i bambini, dopo qualche tentativo, rispondevano: «con»! La preposizione «con».
Fare grammatica, fare anche l’analisi del periodo in questo modo, facendo derivare dall’essere e dall’incontro fra esseri tutto ciò che noi abbiamo stigmatizzato nelle categorie aristoteliche, è un dono straordinario che noi possiamo fare ai nostri figli cosicché un domani, da adulti, possano davvero riuscire a vedere il mondo con gli occhi della fraternità, della libertà e dell’uguaglianza.
È una responsabilità molto grande per il futuro dell’umanità.